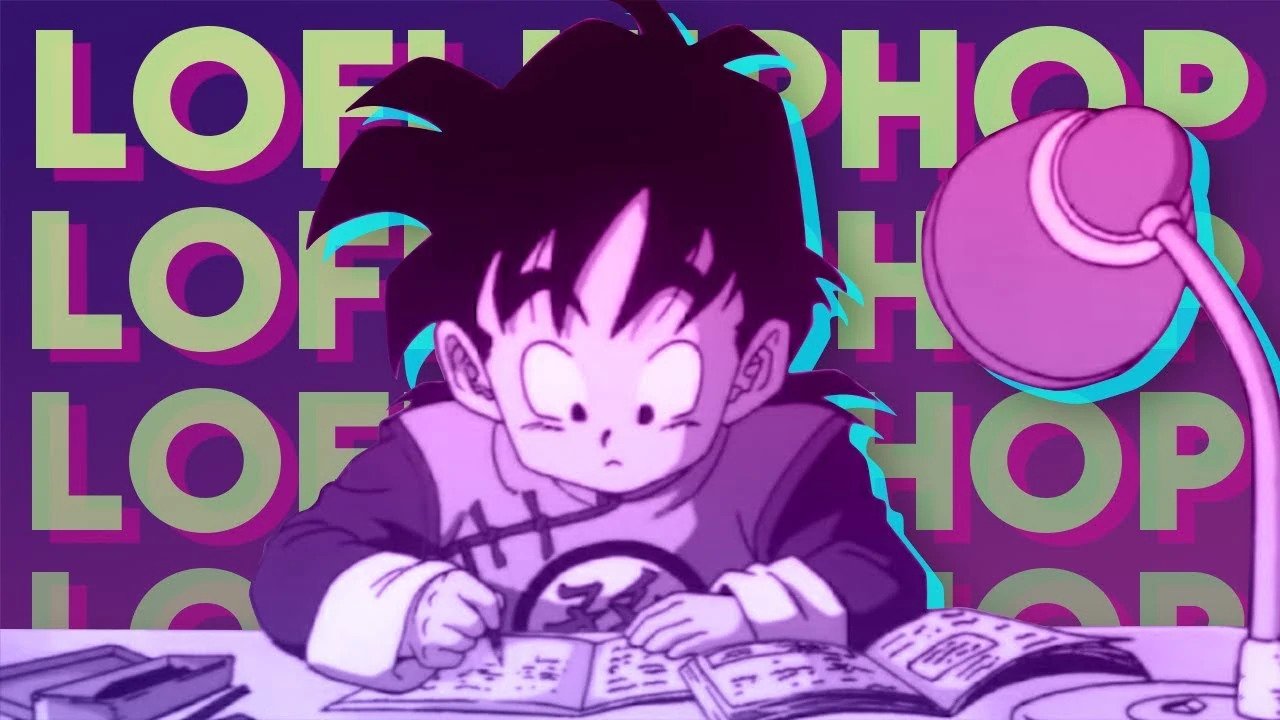Era da molto tempo che non visitavo una mostra artistica. L’ultima volta sarà stata tre anni fa, all’epoca della pandemia, quando presi un aereo per Marsiglia con una vaga idea di unirmi al corpo militare della Legione Straniera. Una fantasia che aveva fondamenta molto traballanti sin dall’inizio ma che tuttavia mi ha permesso di viaggiare un po’. Dopo quella parentesi fallimentare, decisi di prendere un treno per Parigi, città che non avevo mai conosciuto appieno. Girovagando per Champs-Élysées, mi fermai in una piccola struttura che ospitava i lavori di un artista emergente.
L’intero locale era ricoperto di poesie e disegni che spaziavano dallo stile fumettistico a vere imitazioni dei capolavori del Louvre e, in sottofondo, aleggiavano le note di una di quelle vecchie canzoni francesi che penseresti esistano solo nei film. L’atmosfera era onirica e, ora che ci penso, rappresenta uno dei ricordi più nitidi che ho. Avevo appena finito l’Università, abbandonato il Regno Unito e credevo non ci fosse limite a quel che potevo fare, esattamente come quell’artista emergente che aveva aperto la galleria. Peccato ci fossi solo io a visitarla. Secondo me meritava…
La mostra di Isabelle Wenzel
La mia ultima mostra artistica, invece, risale a pochi giorni fa con l’anteprima dell’evento di Isabelle Wenzel tenutosi a BiM – dove Bicocca incontra Milano, in Viale dell’Innovazione 3, una struttura di rigenerazione urbana che ha dato ufficialmente il via ad una moltitudine di eventi artistici, culturali e sociali.

Il tema della mostra era incentrato sulla vita d’ufficio sotto il punto di vista di un artista, tradotto in fogli A4 che volano per aria, telefoni appesi al muro, posizioni scomode assunte dal corpo costretto a rimanere seduto per ore e ore di fronte ad un computer.
Isabelle Wenzel, artista poliedrica che al tempo stesso può vantare dei titoli di fotografa e acrobata, ha affermato che la sua idea era quello di immedesimarsi in uno schema di lavoro 9-5 , la frustrazione che ne può scaturire, ma anche il senso di tranquillità che una routine di ufficio può regalare dal punto di vista di un guadagno fisso.

Coniugare il mondo dell’artista con quello dell’impiegato può sembrare all’apparenza azzardato considerando la distanza tra le due professioni. Tuttavia, potrebbe aver più senso di quel che si potrebbe pensare: solo dalla frustrazione di un lavoro non pienamente apprezzato si può generare la forza creativa (o distruttrice) per esprimere sé stessi al meglio. Mi viene in mente il narratore senza nome di Fight Club, anche lui un impiegato, che dà sfogo alla sua passività tramite gli haiku che distribuisce in ufficio o tramite l’organizzazione socio-anarchica che il suo alter-ego, Tyler Durden, fonda.
Per non parlare di American Psycho, con un Patrick Bateman all’apparenza ben inserito nella società e nell’idilliaca vita da yuppie di Wall Street ma che sfoga il suo dubbio esistenziale e senso di inferiorità uccidendo e torturando persone di un’estrazione sociale inferiore alla sua.
O dell’insofferenza di David Martinez per la scuola, preludio al mondo del lavoro, descritta nel primo episodio di Cyberpunk: Edgerunner e che sfocia nel suo odio per le corporazioni e il suo ingresso nella vita criminale.
Gli esempi sono molti. Soffocare la libertà personale e la voglia di esprimersi in nome del progresso e dell’efficienza può portare lentamente ad una lenta distruzione della personalità per più di una persona. Almeno questo è il messaggio che ho recepito. Se questo è il caso, risulterebbe davvero difficile trovare un equilibrio. L’iniziativa dell’artista è tanto affascinante quanto provocatoria e merita senza dubbio una visita.
La mostra è visitabile gratuitamente fino al 15 settembre e sarà esposta alla C41 Gallery, uno spazio di sperimentazione artistico curato dalla casa di produzione creativa C41.

Ma le novità non finiscono qui. Fulcro del programma temporaneo di eventi gratuiti promosso da BiM sarà il BiM Garden, uno spazio verde a cielo aperto progettato da Paola Navone – Otto Studio e dal paesaggista Antonio Perazzi, con ampi tavoli sociali multifunzionali. Qui, BiM presenta la rassegna estiva di cinema all’aperto “La linea milanese”, curata da Cineteca Milano: un omaggio all’originalità dei grandi capolavori del cinema milanese che traccia una linea lunga 40 anni tra Dario Fo e Maurizio Nichetti, De Sica e Zavattini, Tognazzi e Bianciardi.